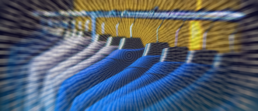Deforestazione zero: interessate 127 mila MPI e 50mila imprese artigiane, import per 36,6 miliardi €. I dati nel webinar Confartigianato
Per contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, la normativa europea contenuta nel Regolamento Ue 2023/1115 impone alle imprese di garantire che i prodotti venduti nell'Unione europea non siano all’origine di deforestazione. La nuova normativa interessa sette materie prime - bovini, caffè, soia, palma da olio, cacao, gomma e legno – e i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando queste materie prime come, ad esempio, cuoio, cioccolato, mobili, olii e pneumatici.
La regolamentazione determina un impatto significativo sugli scambi con l’estero e sull’attività delle imprese italiane in 19 settori relativi alle 7 materie prime e i 77 prodotti associati nell’Allegato 1 del Regolamento Ue 2023/1115. Il perimetro delle micro e piccole imprese interessate è delineato nel report ‘Deforestazione zero: prodotti regolamentati e sistema delle MPI’ predisposto dall’Ufficio Studi e il Sistema imprese di Confartigianato. Qui per scaricarlo.
Il webinar – L’analisi delle novità normative è stata al centro del webinar del 21 maggio 2024 ‘Deforestazione zero, l’impatto sull’artigianato e sulle piccole imprese’ organizzato dal Sistema Imprese della Direzione Politiche economiche di Confartigianato. Nel corso dei lavori, dopo l’introduzione di Guido Radoani, Responsabile del Sistema Imprese e la presentazione del report da parte di Enrico Quintavalle, Responsabile dell’Ufficio Studi, sono intervenuti Elisabetta Morgante, MASAF – Autorità Competente EUTR-FLEGT-EUDR sui nuovi obblighi del regolamento Deforestazione Zero e Angelo Mariano, Conlegno – Responsabile dell’Area Tecnica Legnok, sulla transizione delle imprese dall’EUTR all’EUDR.
Gli highlights del report - Nei comparti esaminati operano 127mila micro e piccole imprese (MPI) e 50mila imprese artigiane che rappresentano il 38,5% del totale delle imprese nei settori in esame, quota quasi doppia rispetto alla media del 22,8% riferita al totale economia. Le MPI nei 19 settori interessati generano un fatturato di 92,9 miliardi di euro e un valore aggiunto di 25,5 miliardi di euro. con Una maggiore presenza di imprese si osserva nei settori che si riferiscono a prodotti in legno e mobili, prodotti da forno, articoli in pelle, prodotti dolciari e articoli in gomma.
Nel 2023 ammontano a 359,6 miliardi di euro le importazioni di prodotti regolamentati dei 27 paesi dell’Unione europea, di cui 106,7 miliardi di euro da paesi extra UE. Nel dettaglio, l’Italia importa 36,6 miliardi di euro di prodotti regolamentati, con 13,3 miliardi di euro da paesi extra UE.
Il focus sul legno – Nei settori afferenti alla materia prima legno operano 52mila MPI e le imprese artigiane rappresentano il 59,5% del totale. I prodotti riferiti al legno costituiscono il 47,3% delle importazioni regolamentate italiane, di cui la metà (51,8%) si riferisce a prodotti di carta.
L’analisi della geografia degli approvvigionamenti di legno, sulla base della classificazione dei paesi delle Nazioni Unite per dinamica delle aree forestali in rapporto alla superficie terrestre, evidenzia che il 56,4% dell’import di legno proviene da paesi con un peso delle aree forestali stabile negli ultimi cinque anni, il 31,7% proviene da paesi in miglioramento e l’11,8% proviene da paesi con un deterioramenti.
Nelle 14 province di confine – in cui sono localizzate circa 6mila imprese del settore legno e mobili - le importazioni di legno sono di circa un miliardo di euro e il 30,2% di queste proviene dai paesi confinanti.
MPI nei settori interessati da Regolamento Ue 2023/1115 su deforestazione per materia prima
2021, imprese attive settori non commerciali e incidenza % artigianato - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Import dell’Italia per materia prima interessata da Regolamento Ue 2023/1115 su deforestazione
Anno 2023. Miliardi di euro e % sul totale - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Key data della filiera auto: occupati autoriparazione artigiana +34% vs grandi imprese che producono auto
Durerà fino al 20 maggio ‘Sostenibilità in tour’, il viaggio a tappe di Confartigianato nella mobilità green che esplorerà le sfide e le opportunità legate alle nuove tecnologie dei veicoli, alla pianificazione urbana, alle infrastrutture, all’impatto sull’attività delle imprese, sull’occupazione e sugli stili di vita dei cittadini.
La mobilità sostenibile si intreccia con l’offerta caratterizzata da oltre 175mila imprese della filiera auto in Italia, con 557 mila addetti. Circa 7 addetti su 10 (69,4%) occupati nella filiera, equivalenti a 387mila addetti, lavorano in micro-piccole imprese con meno di 50 addetti (MPI). Le evidenze sulla mobilità sostenibile sono contenute nella Nota dell’Ufficio Studi ‘Citemos 2024 – key data’ predisposta per l’evento ‘Sostenibilità in tour’. Qui il post #Dati #SuMisura su Linkedin.
L’artigianato ha un ruolo predominante nella filiera auto. Nelle 58mila imprese artigiane di autoriparazione lavorano 156mila addetti il 33,7% in più dei 117 mila addetti delle grandi imprese (con oltre 250 addetti) che producono autovetture in Italia. La filiera auto è una delle declinazioni settoriali della predominanza degli addetti delle imprese artigiane rispetto a quelli dei gruppi multinazionali italiani.
Il cambiamento in corso nel mercato dell’automobile richiede nuove competenze nelle imprese di autoriparazione, ma queste risultano molto difficili da reperire. Nel 2023 sono richiesti 36.330 meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili, di cui 25.730, pari al 70,8%, sono difficili da reperire, quota di oltre 25 punti superiore 45,1% della media di tutte le professioni.
Per le assunzioni dove viene richiesta una elevata attitudine al risparmio energetico la difficoltà di reperimento sale al 72,0%, mentre è più critica la carenza della competenze più legate allo sviluppo del digitale e della meccatronica: per le entrate dove sono richieste con elevata importanza (medio-alta e alta) competenze digitali di base, la difficoltà di reperimento sale all'81,6% e per quelle in cui sono richieste elevate capacità di applicare tecnologie 4.0 arriva all’83,1%.
In chiave territoriale, tra le maggiori regioni - con almeno mille assunzioni di meccanici e manutentori auto - la più elevata difficoltà di reperimento si rileva in Piemonte-Valle d'Aosta dove è pari all’82% delle entrate totali, seguita da Campania con 75,9%, Sicilia con 75,6%, Puglia con 74,5%, Veneto con 73,6%, Toscana con 71,1%, Lombardia con 68,2%, Emilia Romagna con 65,8%, Trentino Alto Adige con 63,8%, Lazio con 56,6%. Tra le altre regioni, si osservano quote superiori alla media per Basilicata (85,7%), Sardegna (81,6%), Abruzzo (77,3%) e Marche (76,7%).
Difficoltà di reperimento lavoratori per totale imprese e meccanici artigianali e manutentori di automobili
2023, % entrate - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Anpal
Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili entrate totali e difficili da reperire
anno 2023, maggiori regioni con almeno 1000 entrate, ordine decrescente per % difficile reperimento - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Anpal
Crisi della moda: nel 2024 le imprese perdono 15 milioni di euro di ricavi al giorno
La moda è il comparto manifatturiero in maggiore difficoltà nella delicata attuale fase congiunturale, dominata dal calo degli scambi internazionali e dai rischi della geopolitica. Nel primo trimestre del 2024 la produzione manifatturiera scende dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti e del 3,1% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La moda è il settore del made in Italy che segna la performance peggiore, con la produzione del tessile, abbigliamento e pelli che segna un calo congiunturale del 3,5% e dell’8,8% su base annua, con una grave accentuazione (-9,3%) a marzo del 2024. Nel dettaglio per settore, il calo della produzione del 4,8% registrata nel comparto del tessile si amplifica al -8,9% per l'abbigliamento e arriva alla doppia cifra (-14,8%) per la pelle.
Le proposte urgenti per rilanciare il comparto sono al centro dell'appello lanciato in questi giorni al Governo e al mondo bancario da Confartigianato Moda e CNA Federmoda, dopo gli incontri del Tavolo Nazionale della Moda del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in cui è stato analizzato lo stato di difficoltà del settore.
Nel 2023 nella moda il fatturato è pari a 97,5 miliardi di euro. Nel primo bimestre del 2024 il valore dei ricavi nel tessile, abbigliamento e pelli scende del 5,1% su base annua: sulla base di questo andamento si calcola una perdita di ricavi pari di 15 milioni di euro al giorno.
Debole anche il commercio al dettaglio: nel primo trimestre del 2024 le vendite di abbigliamento e pellicce salgono dell’1,3% su base annua e quelle di calzature, articoli in pelle e da viaggio del +0,8%.
Pesante segno negativo nei giudizi sugli ordini e nelle attese per ordini e occupazione, mentre rimangono in territorio positivo nella media della manifattura.
La crisi del commercio internazionale pesa sulle vendite all’estero: nel 2023 il valore dell’export ha ristagnato (-0,3%) e mantiene un trend debole anche nella prima parte del 2024 (+0,8% nel primo bimestre). Una analisi territoriale evidenzia che nel 2023 tra le maggiori regioni, i cali più ampi delle esportazioni per tessile, abbigliamento e pelli si osservano in Toscana con -9, Lazio con -5,1% e Veneto con -3,2%. Tra le maggiori province – con almeno un miliardo di euro di export della moda - si registrano cali a doppia cifra per Bologna con -11,7% e Firenze con -11,4%. Segno negativo anche per Verona con -8%, Vicenza con -6,7%, Prato con -5,8%, Treviso con -4%, Varese con -2,6% e Como con -2,1%.
Moda, settore ad alta vocazione artigiana - La crisi in corso colpisce in modo pesante il sistema della piccola impresa e dall’artigianato. Nel settore sono attive 49.593 micro e piccole imprese con 279mila addetti, il 61,5% del totale del settore. Le 34mila imprese artigiane attive danno lavoro a 139 mila addetti, pari al 30,6% dell’occupazione della moda.
Trend della produzione manifatturiera nel primo trimestre 2024 per settore
Gennaio-marzo 2024, var. % tendenziale, corretti per gg. lavorativi - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Attese sugli ordini: manifattura e moda
Gennaio 2012-marzo 2024, saldo - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Italia, da lumaca a gazzella dell’economia europea. L’analisi di Confartigianato su IlSussidiario.net
Prima della pandemia l’economia italiana presentava caratteri di debolezza che ne hanno limitato la crescita. Tuttavia, nella successiva fase di ripresa, l'Italia ha mostrato una straordinaria capacità di reazione. Nonostante le sfide come l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la crisi energetica e la stretta monetaria, anche grazie al sostegno del PNRR, l'Italia è cresciuta più degli altri maggiori economie europee, registrando diversi successi sul fronte del lavoro, dell’export e dell’accumulazione di capitale. Nonostante il miglioramento, c'è ancora molto da fare sul fronte delle riforme per colmare i ritardi strutturali dell'economia italiana e affrontare le sfide poste dal declino demografico. Il ritorno dell’austerità fiscale potrebbe compromettere alcuni dei risultati raggiunti.
L’analisi dell’Ufficio Studi sul dinamismo dell’economia italiana nella ripresa post pandemia è proposta nell’articolo SCENARIO PIL/ I numeri: così l'Italia è diventata la "gazzella" dell'economia europea a firma di Enrico Quintavalle, pubblicato oggi su IlSussidiario.net.
Quando l’Italia era la ‘lumaca’ d’Europa - L'economia italiana nel corso degli anni Dieci ha messo in evidenza una bassa crescita, con il PIL pro capite che nel 2019 era ancora inferiore del 5,3% al livello del 2007, precedente allo scoppio della Grande crisi. La bassa crescita ha reso gli italiani relativamente meno ricchi nel confronto europeo e, mettendo sotto stress il rapporto tra debito pubblico e il PIL, ha favorita la crisi del debito sovrano del 2011-2012. Il tono dimesso degli investimenti privati ha penalizzato la produttività e la digitalizzazione delle imprese, mentre sono crollati gli investimenti pubblici. Le criticità dei fattori di competitività hanno ridotto le quote di mercato del made in Italy nel mondo.
L’Italia si trasforma in ‘gazzella’ - Con la pandemia il Paese è uscito dalla palude della stagnazione dei primi quindici anni del XXI secolo, mostrando una straordinaria capacità di reazione e resilienza. Un sistema caratterizzato da una diffusa presenza di micro e piccole imprese (MPI) – basti pensare che gli occupati nelle MPI sono il triplo della somma degli addetti in Italia dei gruppi multinazionali esteri e italiani - se da un lato ha maggiormente subito la violenta recessione innescata dalla pandemia, dall'altro ha saputo reagire con flessibilità, generando valore e stimolando una crescita più intensa rispetto gli altri maggiori paesi europei.
La forte incertezza conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una crisi energetica che nell’autunno del 2022 ha visto più che raddoppiare il costo di elettricità e gas e una stretta monetaria deflazionistica di intensità senza precedenti nella storia dell’Euro avrebbero potuto fermare la ripresa dell'economia italiana ma, sorprendentemente, questo non è avvenuto. Anzi, l'Italia ha proseguito a crescere più degli altri maggiori paesi europei, arrivando a creare più di un milione di posti di lavoro in due anni. Anche grazie al sostegno degli interventi del PNRR, l'economia italiana, seconda in Europa per produzione manifatturiera, ha evitato la recessione mentre il gigante tedesco nel 2023 ha segnato un calo del PIL dello 0,3%, per ristagnare (+0,2%) quest'anno.
I risultati - Vediamo nel dettaglio alcune delle performance del sistema delle imprese e dell'economia italiana in questi ultimi anni. Tra il 2019 e il 2023 il PIL pro capite in termini reali in Italia ha cumulato un aumento del 4,7%, un ritmo più che doppio del +2,1% dell'Eurozona, e mostrando una marcia in più rispetto al ristagno di Francia e Spagna (+0,1%) e alla flessione della Germania (-1,0%). Nonostante la politica monetaria abbia penalizzato la spesa per interessi del bilancio italiano, la più alta nel continente europeo, la crescita economica ha contenuto la dinamica del peso del debito pubblico: negli ultimi quattro anni il rapporto debito/PIL è salito di 4,5 punti nell'Eurozona, di 12,7 punti in Francia, di 9,5 punti in Spagna Germania, ma solo di 3,1 punti in Italia, che ha fatto meglio della Germania (+4 punti).
Sui mercati esteri si è consolidato il successo del made in Italy, con il volume delle esportazioni manifatturiere che è salito dell’8,6% in quattro mentre è ristagnato (-0,6%) in Germania ed è sceso in Francia (-3,8%).
La crescita della domanda di lavoro delle imprese nell’ultimo biennio ha portato ad un aumento di 3,3 punti percentuali del tasso di occupazione, più ampio degli aumenti di 2,1 punti della media europea, di 2,7 punti della Spagna, di 1,6 punti della Germania e di 1,2 punti della Francia. Nella fase espansiva del mercato del lavoro sale l’occupazione dipendente stabile, quella dei giovani e quella del Mezzogiorno.
Sul fronte del lavoro, persiste un elevato cuneo fiscale, che però negli ultimi quattro anni si è ridotto di 2,8 punti a fronte dei cali più contenuti di Germania (-1,4 punti) e Francia (-0,3 punti) e dell’aumento registrato in Spagna (+0,8 punti).
Nonostante il caro-tassi più severo, grazie al più contenuto indebitamento delle famiglie e alla maggiore crescita dell'occupazione, tra il 2021 e il 2023 in Italia si è registrata una crescita della spesa per consumi del 6,1%, più che doppia del +3,0% della Germania e del +2,6% della Francia.
Il sostegno della politica fiscale ha accelerato il trend degli investimenti, un asset chiave per le transizioni digitale e green delle imprese. Tra il 2019 e il 2023 gli investimenti in macchinari e impianti - al netto dei mezzi di trasporto - in Italia sono saliti del 19,7%, un tasso triplo della media dell'Eurozona, facendo meglio della Francia (+10,1%) e in controtendenza rispetto al calo del 3,2% osservato in Germania. La propensione ad investire accelera rispetto al trend di crescita del 14,9% registrato nel quadriennio precedente, che fu più in linea con il +13,3% della media europea.
Le prospettive - Anche a fronte di queste performance, rimane lunga la strada per colmare i ritardi strutturali dell'economia italiana, mentre andrebbe intensificato il programma delle riforme. Pesano l'elevata burocrazia, mentre la dipendenza energetica si associa ad alti prezzi dell’energia e a fonti rinnovabili ancora non pienamente sfruttate. La tassazione del lavoro, seppur diminuita, rimane elevata e pesa sulla competitività del made in Italy. La demografia non fa sconti: l'Italia ha un peso della popolazione anziana del 24,0%, ben 2,7 punti superiore alla media della già vecchia Europa. Tra il 2028 e il 2023 la popolazione adulta in età lavorativa (20-64 anni) è scesa di 1 milione 285 mila unità, pari ad un calo del 3,6%, a fronte della tenuta registrata in Francia (+0,5%) e Germania (0,0%) e dell’aumento (+3,0%) osservato in Spagna. La minore offerta di lavoro aumenta la carenza di manodopera per le imprese: nel periodo in esame la quota di assunzioni difficili da reperire è salita di quasi venti punti, arrivando al 45,1% nel 2023. La composizione demografica sbilancia la spesa per welfare: l'Italia è al terzo posto nell'Unione europea per spesa pubblica per la protezione sociale, ma scivola al ventiduesimo posto per interventi a favore delle famiglie e dei giovani. Diventa essenziale la gestione dei flussi migratori. Secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, nei prossimi cinque anni nell’Unione europea la popolazione aumenterà di 2,4 milioni mentre quella dell'Africa salirà di 181 milioni. In pratica, nel giro di soli sessanta mesi, dalla piattaforma africana nasceranno tre Italie.
Last but not least, con l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo e l’applicazione delle nuove regole del Patto di stabilità e crescita, il ritorno ad una politica fiscale restrittiva potrebbe imprimere una brusca frenata ai processi di sviluppo dell’economia italiana.