A Match Point la sfida per le imprese: restare competitive nella normalità del disordine
Come restare impresa, umana e competitiva, nella “normalità del disordine” che caratterizza il nostro tempo. Questo il filo conduttore dei due giorni di Match Point, l’appuntamento annuale, svoltosi a Roma l’8 e il 9 settembre, in cui Confartigianato ha riunito quasi 350 rappresentanti di vertice del Sistema Associativo per fare il punto, dopo la pausa estiva, sui temi e con i protagonisti dell’attualità economica e politica e sulle sfide che attendono l’Italia e gli imprenditori.
Ad aprire i lavori, moderati da Annalisa Bruchi, giornalista Rai, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, che ha offerto una lettura lucida della fase storica che stiamo attraversando. “Il match point – ha esordito – è il momento decisivo della partita. E oggi siamo proprio lì: in un tempo non lineare, disordinato, che richiede visione, responsabilità e fiducia”.
Granelli ha ribadito il ruolo cruciale delle imprese artigiane come punti di riferimento nella complessità, luoghi dove “si trasmettono saperi, si costruisce comunità, si fa coesione sociale”. Ha tracciato le priorità dei prossimi mesi: dalla riforma della legge quadro dell’artigianato alla nuova Artigiancassa, dalla riforma dei Confidi al tema cruciale dell’accesso al credito, senza dimenticare la necessità di politiche industriali incisive, anche a livello europeo.
“Dentro il disordine – ha detto – le nostre imprese non arretrano: lo attraversano, lo trasformano. È questo che rende l’impresa artigiana una risorsa non solo economica ma civile e culturale per il Paese”.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio ha sottolineato il ruolo essenziale delle micro, piccole e medie imprese nel tessuto produttivo nazionale. “I dati parlano chiaro – ha ricordato – l’occupazione è ai massimi storici anche grazie al lavoro delle imprese artigiane”. Urso ha assicurato il pieno sostegno del Governo, richiamando i recenti interventi a favore del comparto: dalla legge annuale per le PMI – finalmente in via di approvazione – alle misure per favorire il ricambio generazionale, lo sviluppo delle start-up, la digitalizzazione e il rafforzamento del Made in Italy. “Nessuna intelligenza artificiale – ha concluso – potrà mai sostituire la passione artigiana e la qualità del fare italiano”.
Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio Studi di Confartigianato, e Monsignor Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, hanno insistito sulla stessa urgenza: rimettere al centro il lavoro come motore di coesione sociale e di sviluppo umano, in un mondo sempre più instabile e incerto. Secondo Quintavalle la crisi è profonda, ma affrontabile. Serve una migliore programmazione della spesa pubblica, una gestione più efficiente degli incentivi e un’azione coordinata per ridurre i gap strutturali che ostacolano la crescita delle micro e piccole imprese. Monsignor Giuseppe Baturi, con un intervento ispirato alla dottrina sociale della Chiesa e alla lezione della Rerum Novarum, ha detto che l’artigiano incarna un modello di lavoro “prossimo”, radicato nel territorio, capace di coniugare libertà e responsabilità. Un modello che “fa bene alla democrazia”, perché fondato su relazioni umane autentiche, solidarietà e partecipazione. Baturi ha anche lanciato un monito sull’impatto dell’intelligenza artificiale: se da un lato offre opportunità, dall’altro rischia di omologare la razionalità produttiva, allontanandola dai bisogni reali delle persone e dei territori. Il rischio è una dequalificazione del lavoro e la perdita di senso del fare umano. Per questo ha richiamato la necessità di un “dialogo tra scienza e coscienza”, capace di guidare l’innovazione in funzione del bene comune. Ha concluso rilanciando l’appello di Papa Francesco a un’“alleanza per la speranza”, che coinvolga imprese, lavoratori, istituzioni e società civile. Una partecipazione diffusa, che metta il lavoro al centro come strumento di pace e dignità.
Da parte sua, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo ha lanciato un monito sulle potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie, sottolineando l’importanza di una guida morale e culturale. Ha poi sottolineato l’unicità italiana, un Paese fatto di territori diversi, di culture locali forti, di eccellenze artigianali e agricole, ribadendo che questa ricchezza è un punto di forza, non una debolezza, e criticando la perdita di fiducia degli italiani in se stessi, testimoniata dal crollo delle nascite e dalla fuga dei giovani all’estero. “Essere italiani – ha detto – è una fortuna e una responsabilità. Occorre recuperare fiducia nel futuro, valorizzare il nostro patrimonio e trasmettere ai giovani l’orgoglio di appartenere a questo Paese straordinario”.
Ivana Pais, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha analizzato l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, partendo dal modello fordista fino alle attuali piattaforme digitali. Le competenze richieste si sono spostate dalle hard alle soft skill, valorizzando la capacità di autopresentazione e comunicazione, anche nei settori professionali. Allo stesso tempo, la formazione si frammenta in micro-credenziali. Più che la disoccupazione tecnologica, preoccupa il mismatch tra competenze richieste e disponibili. Pais ha proposto un modello di intelligenza artificiale partecipativa, in cui l’introduzione delle tecnologie sia condivisa tra lavoratori e imprese, per una transizione digitale più consapevole e inclusiva.
E in tema di lavoro, Mauro Magatti, docente di sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha osservato che oggi oscilla tra realizzazione personale e sfruttamento, senso e alienazione. In Italia il numero di lavoratori è il più alto mai registrato, ma prevalgono salari bassi e incertezza, con una società a “clessidra” dove il ceto medio si restringe. Solo una minoranza si sente davvero coinvolta nel lavoro, mentre molti non trovano ancora soddisfazione o sicurezza, soprattutto in un contesto di grande ansia e transizione, accentuata dalla digitalizzazione, che rappresenta una trasformazione più radicale della rivoluzione industriale. Il lavoro artigiano, secondo Magatti rappresenta una sfida di libertà contro la standardizzazione imposta dalla digitalizzazione e dalle grandi piattaforme. L’artigiano non applica semplicemente la tecnologia, ma la manipola, creando unicità e valore locale. Il lavoro artigiano può rispondere alle richieste di autonomia e senso dei giovani, ma deve affrontare rischi di instabilità e migliorare la qualità delle relazioni interne. Per questo è fondamentale sostenere la formazione e preservare questa matrice culturale che valorizza la persona radicata nella comunità, capace e relazionata, contrastando l’uniformità del modello standardizzato. In sintesi, lavoro, giovani e artigiani affrontano sfide complesse, ma esistono risorse e potenzialità su cui lavorare per costruire un futuro più solido e significativo.
Elena Granata, docente al Politecnico di Milano, ha richiamato il declino della “bella Italia” tra borghi e città, oggi minacciata dalla mancanza di case accessibili e dal modello economico che favorisce solo pochi territori attrattivi, abbandonando molte aree interne, e ha sottolineato l’urgenza di garantire alle nuove generazioni il diritto a un progetto di vita stabile, radicato nei luoghi. Critica verso l’idea di sovrascrivere i territori con modelli globalizzati e distruttivi, ha invitato a riscoprire un modello di sviluppo e leadership ispirato alla tradizione mediterranea, fondato sulla cooperazione, il legame con i luoghi e le comunità.
Francesco Maietta, responsabile Area Consumi Mercati e Welfare del Censis, e Sara Lena, ricercatrice del Censis, hanno illustrato i risultati del quinto Radar Artigiano Confartigianato-Censis da cui emerge che il valore artigiano si diffonde anche oltre le imprese formalmente riconosciute come tali. Dall’indagine su 500 imprese nate dopo il 2009 emerge che oltre la metà delle imprese non artigiane condivide caratteristiche tipiche dell’imprenditore artigiano (gestione diretta, lavoro manuale) e valori come qualità, personalizzazione, competenze artigiane, sostenibilità e tutela delle tradizioni. Le imprese affrontano difficoltà comuni, quali burocrazia, accesso al credito, costi energetici e soprattutto la crescente difficoltà a reclutare lavoratori qualificati, nonostante l’artigianato sia attrattivo per i giovani. Si evidenzia inoltre una buona diffusione dell’uso del digitale e una propensione agli investimenti, soprattutto in sostenibilità e digitalizzazione. Nonostante le trasformazioni radicali degli ultimi decenni, dalla digitalizzazione alle sfide ambientali, il valore artigiano non solo non è venuto meno, ma si è consolidato nella cultura sociale italiana. L’impresa artigiana viene apprezzata non solo per la sua capacità di creare ricchezza e occupazione, ma anche per il suo impegno nella coesione sociale, nella sostenibilità e nel rapporto con il territorio.
La seconda giornata di Match Point, condotta da Sebastiano Barisoni, Vice Direttore esecutivo di Radio 24, ha visto l’intervento del Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, secondo il quale “i fondi europei rappresentano una risorsa cruciale per il Paese, ma l’attenzione va spostata dalla quantità alla qualità della spesa. Una parte significativa delle risorse, dal PNRR ai Fondi di Coesione, raggiunge direttamente il sistema delle imprese e l’artigianato, rendendo fondamentale l’uso corretto di ogni euro”. Per quanto riguarda il PNRR, Foti ha sottolineato che l’ansia principale non deve essere “quanto abbiamo speso”, ma “se stiamo spendendo bene”. Il piano prevede una spesa totale di 194 miliardi, ma 122 sono a debito, il che rende ancora più importante l’utilizzo dei 72 miliardi a fondo perduto. L’Italia sta procedendo: sono stati aperti 365.000 progetti e 202.000 sono già stati conclusi. La spesa certificata ammonta a circa 83 miliardi di euro, ma il Ministro ha ribadito la necessità di semplificare le procedure burocratiche che penalizzano soprattutto i piccoli Comuni. Sul fronte dei Fondi di Coesione, Foti ha annunciato un risultato storico: l’Italia ha rendicontato il 99,18% dei fondi della programmazione 2014-2020. Nonostante i ritardi della nuova programmazione (2021-2027) dovuti al Covid e alla sovrapposizione con il PNRR, la Commissione Europea ha proposto una riprogrammazione volontaria che permette alle Regioni di investire in settori strategici. Tra questi, l’innovazione, la resilienza idrica, l’approvvigionamento energetico, il social housing e la difesa da minacce ibride, come attacchi informatici e disinformazione. Foti ha concluso con un messaggio chiaro: la ricchezza è creata dall’impresa, e non dallo Stato. L’Italia, con il suo ampio paniere di prodotti esportati, deve sostenere le sue filiere e battersi in Europa per ottenere regole più semplici e una burocrazia snella, perchè la burocrazia ha un costo che, ha detto, “oggi equivale a quello dei dazi americani”. Il Ministro ha infine lanciato un appello a valorizzare l’intelligenza umana, che non deve essere offuscata dall’avanzata di quella artificiale, ribadendo l’impegno del governo a sostenere le imprese che sono il vero motore del Paese.
I lavori della seconda giornata si sono articolati in un intenso confronto tra relatori di primo piano, ciascuno portatore di una visione chiara e profonda sui mutamenti in atto. Uno sguardo alla storia e alle ciclicità dell’economia mondiale è arrivato da Giulio Sapelli, economista e Presidente della Fondazione Germozzi, che ha analizzato il ruolo degli Stati come attori nell’economia in un contesto di globalizzazione spinta.
Raffaello Lupi, docente dell’Università Tor Vergata di Roma, si è soffermato sugli effetti dei dazi e delle nuove politiche commerciali globali, evidenziando i contraccolpi sulle imprese italiane e sulle filiere produttive internazionali. Lucio Poma, Capo Economista di Nomisma, ha tracciato il quadro di come stanno cambiando le catene del valore, tra transizioni digitali e nuove priorità geopolitiche che spingono verso un “nearshoring” sempre più spinto. Un passaggio fondamentale è stato quello sull’impatto dell’intelligenza artificiale: Alessandro Aresu, Consigliere scientifico di Limes, ha esplorato la geopolitica dell’I.A., delineando scenari in cui l’innovazione tecnologica ridisegna equilibri e poteri tra le nazioni. Il focus si è poi spostato sulla finanza globale, con l’intervento di Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa, che ha illustrato le nuove dinamiche del “Risiko bancario”, tra aggregazioni, instabilità e nuove sfide per l’accesso al credito. Marco Grazioli, Presidente di The European House – Ambrosetti, ha riferito dei contenuti emersi alla 51° edizione del Forum di Cernobbio svoltosi dal 5 al 7 settembre.
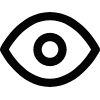 Guarda la galleria fotografica dell’evento
Guarda la galleria fotografica dell’evento
Related posts:
 In 25 Paesi extra Usa +5,3% export. Granelli: “Ue e Italia sostengano imprese”
In 25 Paesi extra Usa +5,3% export. Granelli: “Ue e Italia sostengano imprese”
 Cybercrime, l’allarme di Confartigianato: in 4 anni +45,5% reati informatici contro le imprese
Cybercrime, l’allarme di Confartigianato: in 4 anni +45,5% reati informatici contro le imprese
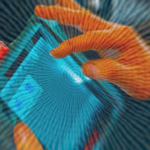 Le competenze digitali e green nell’autoriparazione nel nuovo report sulla filiera auto
Le competenze digitali e green nell’autoriparazione nel nuovo report sulla filiera auto
 Confartigianato protagonista agli “Italian Days” durante la Dubai Fashion Week
Confartigianato protagonista agli “Italian Days” durante la Dubai Fashion Week


