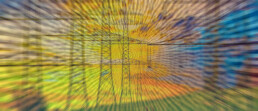STUDI – La frenata dell’economia cinese e i riflessi sul made in Italy. Incertezze globali e #wareconomy nel webinar del 2 maggio
La crisi internazionale nel cuore d’Europa si riverbera sull’andamento dell’economia mondiale. Le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale di aprile indicano una minore crescita del PIL mondiale rispetto alle previsioni di gennaio di 0,8 punti nel 2022. La revisione al ribasso è ingente per la Russia (-11,3 punti) e più accentuata per le due economie europee maggiormente dipendenti dal gas russo, Germania (-1,7 punti) e Italia (-1,5 punti).
Si distinguono gli effetti della frenata dell’economia cinese, con il tasso di crescita che passa dal +8,1% del 2021 al +4,4% del 2022, addirittura inferiore al +4,8% della Spagna. Se escludiamo l’anno della pandemia (+2,2%) per trovare un altro anno in cui l’economia cinese è cresciuta di meno rispetto al 2022, bisogna tornare al 1990.
Già nella seconda metà del 2021 l'economia cinese ha vistosamente ridotto le importazioni e il riacutizzarsi dei contagi da Covid-19 a metà marzo ha portato a nuovi lockdown, riducendo l’attività produttiva e congestionato importanti porti, come quello di Shanghai.
L'analisi dei dati sul commercio estero extra Ue pubblicati oggi dall’Istat evidenzia che nel primo trimestre del 2022 il made in Italy nei paesi extra Ue sale del 21% rispetto allo stesso periodo di un anno prima; tra i paesi monitorati, si registra il tracollo dell'export in Russia (-50,9% a marzo, -8,4% nel primo trimestre) e la bassa performance del mercato cinese che a marzo segna un aumento che si ferma al +1,4% e nel primo trimestre del 2022 cresce di un limitato 2,1%. All’opposto, sono in forte i mercati di Stati Uniti (+34,4%), Regno Unito (+27,5%), India (+26,5%) e Turchia (+23,6%).
Le criticità sui mercati internazionali, acuite dal conflitto tra Russia e Ucraina e intrecciate con l’escalation dei prezzi delle materie prime e delle commodities energetiche saranno al centro del webinar di presentazione del 19° report ‘#wareconomy - la gelata della primavera e le sfide dell'inflazione’ organizzato lunedì 2 maggio 2022 dall’Ufficio Studi e dalla Direzione Politiche economiche, nell’ambito delle Sessioni streaming della Scuola di Sistema, con il seguente programma:
PROGRAMMA WEBINAR 2 MAGGIO 2022, ORE 12.00-13.15
Introduzione di Vincenzo Mamoli, Segretario Generale;
La gelata di primavera e le armi spuntate nella guerra all’inflazione di Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi;
Le tendenze sul territorio di Licia Redolfi, Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia;
Conclusioni di Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche.
Iscriviti al webinar
Trend export nei principali paesi extra Ue nel primo trimestre 2022
Gennaio-marzo 2022, var. % tendenziale - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
STUDI – Prezzi elettricità a marzo +82,3% in Italia, si ferma a +17,6% in Germania e +6% in Francia, effetti recessivi più pesanti nel Mezzogiorno
Il mix di generazione elettrica è alla base del divergente andamento dei prezzi al consumo dell’elettricità riscontrata nei maggiori paesi europei. Nonostante il deragliamento del prezzo del gas, in Italia l’utilizzo di questa commodity è aumentato a fronte di una riduzione nel resto d’Europa.
L’analisi del report mensile dell'Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) dell'Ocse evidenzia la differente reazione delle maggiori economie europee all'escalation dei prezzi del gas, letteralmente deragliati nella seconda metà del 2021. A gennaio 2022, sul totale di energia elettrica prodotta nei dodici mesi, in Germania il 42,6% proviene da rinnovabili, il 29,2% dal carbone, il 14,9% dal gas e l'11,1% dal nucleare. In Francia domina il nucleare, dal quale proviene il 67,4% della produzione di elettricità, seguito dalle rinnovabili con il 23,3% mentre l'uso del gas è limitato al 5,8%. Maggiore esposizione dell'Italia alla bolla dei prezzi del gas, fonte con cui viene prodotta la metà (48,4%) dell'elettricità, superiore al 41,5% della quota da rinnovabili, mente è basso l’utilizzo di carbone (5,4%) e petrolio (3,6%).
Anche l’analisi della tendenza nell’ultimo anno mostra ampie differenze tra i maggiori paesi europei. Sul fronte delle rinnovabili, la produzione eolica è in calo in Francia (-8,9%) e Germania (-5,7%), mentre è in controtendenza in Italia (+5,6%). La produzione da solare sale del 13,1% in Francia e del 4,0% in Germania, mentre ristagna (+0,8%) in Italia. I fenomeni di siccità hanno determinato una diffusa riduzione di produzione di energia idroelettrica.
Nel cuore green dell'Europa, in Germania, la produzione di elettricità con il carbone, oltre ad avere un peso più elevato, sale di molto nell’ultimo anno, segnando un aumento del 20,1%. La Francia, pur registrando un contributo del carbone più limitato, ha aumentato del 61,5% la produzione questa commodity, mentre per l'Italia la crescita si ferma al 5,6%.
E il gas? Costa troppo, e di conseguenza Francia e Germania, che peraltro già lo usano meno, ne riducono ulteriormente l'utilizzo, rispettivamente del 5,1% e del 6,0%. Al contrario l'Italia, con quasi metà dell'elettricità prodotta dalle centrali a gas, ne aumenta l'utilizzo, registrando una crescita del 5,6%; stiamo parlando di una commodity che a dicembre 2021 segna un aumento del 255% dei prezzi all'importazione.
Le differenti matrici di generazione elettrica e le loro evoluzioni nella crisi, determinano un divergente andamento dai prezzi dell'elettricità al consumo. Secondo i dati Eurostat pubblicati giovedì scorso, il prezzo dell'energia elettrica sale dell’82,3% in Italia, un ritmo doppio della media dell’Eurozona, a fronte di un più limitato dinamismo in Germania, dove i prezzi salgono del 17,6%, e in Francia, dove l’aumento si ferma al 6,0%.
Sulla base dell’evoluzione dei prezzi, a parità di consumo, le famiglie italiane nell’ultimo anno hanno speso per l’energia elettrica 5,4 miliardi di euro in più rispetto ai dodici mesi precedenti, pari allo 0,33% del PIL. In chiave territoriale, l’incremento di spesa più elevato in Lombardia con 939 milioni in più, seguita da Lazio con 534 milioni, Sicilia con 464 milioni, Veneto con 463 milioni, Campania con 453 milioni ed Emilia Romagna con 424 milioni.
Gli effetti recessivi sono più intensi nel Mezzogiorno, dove la maggiore spesa è pari allo 0,49% del PIL a fronte dello 0,30% del Centro e dello 0,28% del Nord; la ricaduta più intensa dello shock dei prezzi si registra in Sardegna con la maggiore spesa che è pari allo 0,57% del PIL regionale, seguita da Sicilia con 0,56%, Calabria con 0,54% e Puglia con 0,49%.
L’estensione di queste tendenze sul mercato elettrico delle imprese determinerebbe una perdita di competitività, aggravando la già fragile posizione precedente all’inasprirsi della crisi energetica: nel primo semestre del 2021 una piccola impresa italiana pagava un prezzo dell’elettricità del 12,9% superiore rispetto alla media dell’Eurozona.
L’analisi dell’Ufficio Studi su QE-Quotidiano Energia.
Dinamica prezzi dell’energia elettrica nei maggiori paesi Ue
Marzo 2022, var. % tendenziale - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Produzione elettricità per fonte in Francia, Germania e Italia
Gennaio 2022, ultimi 12 mesi, % sul totale - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Aie
Peso sul PIL della maggiore spesa elettricità delle famiglie nell’ultimo anno per regione
marzo 2022, ultimi dodici mesi, % sul PIL - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Terna
CAAF - Avviata la campagna fiscale 2022. Confartigianato, la tua scelta migliore: competenza, consulenza e risparmio
Il CAAF Confartigianato ha lanciato la campagna fiscale 2022 per l’elaborazione del Modello 730, le Attestazioni ISEE, e tutti gli altri adempimenti rivolti a pensionati e lavoratori dipendenti.
Malgrado la proroga normativa prevista per la messa a disposizione dei dati della dichiarazione precompilata (quest’anno le informazioni saranno disponibili solo a fine maggio) l’attività del CAAF Confartigianato è già iniziata anche su questo fronte con la raccolta delle deleghe e la verifica della documentazione fiscale per l’apposizione del visto di conformità. Considerato che le certificazioni uniche sono disponibili da metà marzo ed i clienti sono obbligati all’esibizione della documentazione relativa agli oneri, l’indicazione fornita alle strutture territoriali è quella di procedere ad erogare il servizio per poi porre a confronto, in un successivo momento e massivamente, i dati della dichiarazione elaborata con quelli della precompilata.
Il termine ultimo per presentare e trasmettere in via telematica il Modello 730 è fissato al 30 settembre, con quattro “finestre temporali” intermedie che partono dal 15 giugno.
Anche quest’anno il CAAF Confartigianato si avvarrà di strumenti innovativi di dialogo con la pubblica amministrazione grazie al rinnovo della convenzione con l’INPS che permette agli operatori di ottenere in tempo reale il dato della Certificazione Unica, con la possibilità di stamparla a beneficio del cliente. Atteso a breve anche il rinnovo della convenzione con l’amministrazione finanziaria per i dati della precompilata.
L’innovazione e la qualità dei servizi sono di casa nei CAAF Confartigianato e un numero crescente di clienti stanno sperimentando la comodità di svolgere parte degli adempimenti direttamente da casa attraverso la piattaforma web Personal CAAF 2.0.
Facilità di utilizzo, semplicità e accesso all’archivio personale, oltre alla possibilità di inviare, con un semplice clic, direttamente all’operatore la documentazione necessaria per l’adempimento ed il servizio richiesto, sono le caratteristiche principali della piattaforma che ogni giorno si arricchisce di nuove funzionalità. E' in arrivo, ad esempio, la possibilità di prenotare direttamente l’appuntamento con il nostro operatore, nel giorno e orario preferito, senza alcuna coda.
CAAF Confartigianato, la tua scelta migliore, competenza, consulenza e risparmio.
STUDI – Effetti della guerra pesano sul recupero dell’occupazione. La resilienza di 41 province nel report di Confartigianato
Il prolungamento della guerra in Ucraina e l'amplificazione della crisi energetica potrebbero interrompere il percorso di recupero della recessione causata dalla pandemia che, sulla base dei dati mensili, a febbraio 2022 vedeva l’occupazione totale registrare un quasi completo recupero (-0,4%) rispetto a febbraio 2020, pur confermano il pesante ritardo per l’occupazione indipendente, già evidenziato in nostre precedenti analisi.
L’analisi è contenuta nell’Elaborazione Flash ‘Le incertezze della guerra sul mercato del lavoro e gli effetti della pandemia’ pubblicata oggi e corredata dai dati territoriali contenuti nell’Appendice statistica ‘Mercato del lavoro nel 2021 per regione e provincia’. Per scaricare il report e l’appendice accedi a 'Consultare ricerche e studi'.
Nel lavoro sono esaminati gli effetti della pandemia sui mercati del lavoro locali, una analisi resa possibile dai dati su base annuale. Nel 2021 il tasso di occupazione (15-64 anni) sale a 58,2%, migliorando di 0,8 punti percentuali rispetto al 2020 ma rimanendo inferiore di 0,8 punti rispetto al livello del 2019.
La resilienza nel territorio – La resilienza nel territorio – L’analisi territoriale, condotta in collaborazione con l’Ufficio Studi di Confartigianato Marche e l’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia, evidenzia che in cinque regioni il tasso di occupazione del 2021 supera quello del 2019: gli aumenti più intensi sono il +1,9 punti della Basilicata, il +0,8 punti del Friuli-Venezia Giulia e il +0,4 punti della Puglia; seguono, in territorio positivo, i +0,3 punti della Liguria e i +0,1 punti della Calabria. In tre regioni l'aumento è determinato dalla crescita della sola componente femminile (Puglia, Calabria e Friuli-Venezia Giulia), mentre in Basilicata sale il tasso di occupazione per entrambi i generi e in Liguria sale la sola componente maschile. All’opposto, si registrano le flessioni più intense per Provincia Autonoma di Bolzano con -3,6 punti, Molise con -2,3 punti e Veneto e Emilia-Romagna, entrambe con -1,9 punti.
In 41 province, in cui si addensa il 27,9% dell’occupazione italiana, si osserva nel 2021 un completo recupero del tasso di occupazione del 2019, in controtendenza rispetto al calo in media nazionale, ed i dieci aumenti più intensi sono quelli di Frosinone (+6,6 punti percentuali), Enna (+4,1 punti), Nuoro (+3,8 punti), Lecce (+3,3 punti), Potenza (+2,6 punti), Lodi (+2,4 punti), Treviso (+2,3 punti), Crotone (+2,2 punti), Ragusa (+2,1 punti) e Livorno (+2,0 punti).
Un analisi per genere mostra che in 18 province, rappresentative del 13,9% dell’occupazione nazionale, si registra un aumento del tasso di occupazione per entrambi in generi; in altre 10 province, che comprendono il 7,1% degli occupati, sale solo il tasso di occupazione femminile mentre per le rimanenti 10 province, rappresentative del 4,7% dell’occupazione, sale solo il tasso di occupazione maschile.
La crisi è stata più pesante in tredici grandi comuni, quelli con la maggiore popolazione, che concentrano il 16,0% degli occupati italiani, nei quali il tasso di occupazione registra una riduzione di 1,9 punti tra il 2019 e il 2021, di intensità più che doppia rispetto alla media nazionale (-0,8 punti). In generale, questi maggiori comuni addensano attività terziarie private e della Pubblica amministrazione e rappresentano un polo di attrazione del turismo presentando quindi una maggiore diffusione di imprese attive nei servizi turistici, culturali e di intrattenimento, i segmenti che sono stati maggiormente colpiti dalla recessione causata dalla pandemia. Pesanti cali del rapporto tra occupati e popolazione per Venezia (-5,8 punti), Firenze (-5,0%), Bologna (-4,4%) e Catania (-4,3 punti); in controtendenza, recuperano i livelli pre-crisi Palermo (+1,1 punti tra 2019 e 2021), Genova (+0,9 punti) e Messina (+0,6 punti).
Tasso di occupazione nelle province: le 41 province in crescita rispetto al 2019
Anno 2021. Variazione in punti percentuali su 2019. 15-64 anni, dati in media annua - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Province per dinamica del tasso occupazione 2019-2021 totale e di genere
dinamiche 2019-2021, occupati in migliaia e % su totale Italia - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
STUDI – La gelata di primavera e le armi spuntate per la guerra all’inflazione. L’analisi di Confartigianato su IlSussidiario.net
Un prolungamento del conflitto nel cuore dell'Europa espone l’economia italiana al rischio di una stagflazione, con ricadute rilevanti sul sistema delle imprese, già impegnato in una delicata transizione post-pandemia. Si delinea una pericolosa sincronizzazione di politiche economiche restrittive, mentre per affrontare questa nuova crisi servirebbe una risposta comune dell’Unione europea, articolata con interventi fiscali espansivi.
L’analisi dell’Ufficio Studi è proposta oggi nell’articolo I numeri della recessione/ La crisi di primavera si abbatte su moda, Pnrr e consumi a firma di Enrico Quintavalle, su IlSussidiario.net.
Le ripercussioni della guerra sulla crisi energetica iniziata lo scorso anno stanno sortendo effetti dirompenti sui bilanci di famiglie e imprese. A marzo il prezzo del petrolio in euro ha raggiunto il massimo storico, superando il precedente picco del marzo 2012. Secondo le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza, il 2022 sarà l'anno del più elevato prezzo in euro del barile di Brent. Il prezzo del gas europeo è deragliato, moltiplicandosi per 5,1 volte negli ultimi dodici mesi.
Questa escalation ha pesanti ricadute sulla bolletta energetica: a gennaio 2022 le importazioni di energia (totale ultimi dodici mesi) salgono di 35,7 miliardi di euro (+121%) su base annua, di cui l’87%, pari a 31,1 miliardi, è dovuto all’aumento dei prezzi e solo il restante 13% (4,7 miliardi di euro) da aumento dei volumi acquistati.
Secondo i dati definitivi pubblicati venerdì scorso, a marzo 2022 l’inflazione accelera per il nono mese consecutivo, raggiungendo il 6,5%. Il 72% dell’aumento dei prezzi, pari a 4,7 punti di inflazione, deriva dai beni energetici, che a marzo, nel confronto internazionale, segnano un aumento del 53,5%, 8,8 punti in più rispetto al +44,7% della media dell’Eurozona, un divario che arriva a 15,9 punti rispetto alla Germania e sale a 24 punti rispetto alla Francia. Una così ampia divergenza penalizza in modo severo la competitività delle imprese italiane, mentre il caro-energia riduce il potere di acquisto delle famiglie. Sulla base degli andamenti dei prezzi dell’energia si calcola (nell’ipotesi di parità di quantità consumate, con una domanda anelastica) che nell’ultimo anno, tra aprile 2021 e marzo 2022, le famiglie italiane abbiano speso per elettricità, gas e carburanti 17,3 miliardi di euro in più rispetto ai dodici mesi precedenti, sottraendo risorse dei bilanci familiari per la spesa in servizi e in beni non energetici. Potrebbero essere colpiti con maggiore intensità quei consumi già pesantemente colpiti dalla recessione: rispetto al livello pre-Covid del 2019, negli ultimi due anni i prodotti della moda e i servizi turistici e di intrattenimento hanno cumulato minori spese delle famiglie per 125,8 miliardi di euro. Una sorta di tempesta perfetta grava sulla moda, unico comparto manifatturiero che non ha recuperato le esportazioni del 2019 oltre ad essere colpito dalle sanzioni commerciali nei confronti della Russia, dalle quali deriva per quest’anno un effetto recessivo sul PIL per 3,6 miliardi di euro.
Lo shock dei prezzi genera effetti di più lungo periodo: al termine della crisi i prezzi di petrolio e gas naturale saranno strutturalmente più elevati, a fronte delle minori esportazioni della Russia, del calo degli investimenti e dei piani di decarbonizzazione.
E mentre la guerra in Ucraina ha occupato la scena dei media, sul fronte della pandemia è da inizio anno che in Cina si registrano lockdown locali che influiscono sull'attività economica della prima economia manifatturiera nel mondo, la quale già dalla seconda metà del 2021 ha registrato una riduzione delle importazioni; nei primi due mesi del 2022 il made in Italy in Cina sale di un limitato 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte del +20% registrato dal totale dei paesi extra Ue.
La produzione manifatturiera italiana, volatile nei primi due mesi dell'anno, nella media dell'ultimo trimestre rilevato (dicembre 2021-febbraio 2022) segna una diminuzione dell’1,2% rispetto al trimestre precedente. Dove si usa più energia il calo dell’attività è molto accentuato: a febbraio 2022 la domanda di gas delle imprese manifatturiere risulta del 9,3% inferiore a quella di un anno fa e a marzo cede il 10,3% rispetto a quella di dodici mesi prima.
Rimane aperta la partita della dipendenza del gas russo: negli ultimi anni, in parallelo alla sfavorevole evoluzione dei rapporti con la Libia, non sono state costruite alternative solide al rifornimento di energia e gli effetti del taglio del cordone ombelicale del gas russo sarebbero molto profondi. L’interruzione di afflussi di gas dalla Russia, nell’ipotesi più severa delineata nel Documento di economia e finanza (DEF 2022) varato lo scorso 6 aprile - una parziale sostituzione determinerebbe una carenza di gas importato del 18% per quest’anno e un più marcato aumento dei prezzi - determinerebbe effetti negativi di 2,3 punti di PIL nel 2022 e di 1,9 punti nel 2023, spalancando uno scenario di stagflazione, una associazione di alta inflazione e stagnazione che non si registrava da quarant’anni.
Per fare fronte a questa gelata di primavera dell’economia e ai rischi che derivano dal prolungamento del conflitto in Ucraina, servirebbero politiche economiche espansive. Nel DEF 2022 è sotteso un debole impulso fiscale, che si ferma a 0,2 punti di maggiore PIL per quest’anno e a 0,1 punti nel 2023, mentre la crescente inflazione ha innescato una politica monetaria meno accomodante. Gli orientamenti espressi a inizio marzo della Commissione europea per una politica di bilancio neutrale nell’Eurozona, con una accentuazione restrittiva nei paesi ad alto debito, delineano per l’Italia una pericolosa sincronizzazione pro-ciclica tra la politica monetaria e quella di bilancio.
Gli spazi di espansione fiscale appaiono insufficienti per affrontare la sfida che la crisi in corso sta ponendo alle economie europee. Vanno ampliati gli interventi finalizzati a ridurre la dipendenza energetica, come le agevolazioni per la produzione e la domanda di energia da fonti rinnovabili, la costruzione di nuovi rigassificatori, gli incentivi per investimenti energy saving in macchinari e nelle abitazioni. Una espansione degli investimenti pubblici in energia rinnovabile fornisce un maggiore apporto alla crescita, come evidenziato in un recente esercizio condotto dall’Ufficio parlamentare di bilancio.
Molti degli interventi per contrastare le ricadute dello shock energetico in corso non sono finanziabili con le risorse nazionali, rendendo necessaria una risposta comune dell’Unione europea che utilizzi l’esperienza di debito congiunto di Next Generation EU, come indicato nelle comunicazioni dello scorso 23 marzo del Presidente del Consiglio Mario Draghi.
Infine, senza le leve di una politica fiscale espansiva sarà difficile accompagnare i processi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), essenziali per una crescita strutturale dell’economia: si tratta di 63 riforme in sei anni, più di dieci all’anno, una sfida senza precedenti.