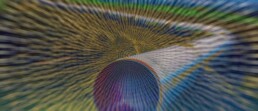STUDI – Caro tassi (+227 punti base) frena il credito alle imprese, ma per investimenti Italia più resiliente rispetto Eurozona
In Eurozona il tasso di inflazione a febbraio 2023 si colloca all’8,5%, in leggero rallentamento rispetto al +8,6% di gennaio. In Italia l’inflazione è del 9,8%, con un più deciso arretramento rispetto al 10,7% di gennaio.
In decisa frenata l'inflazione energetica che in Eurozona scende al 13,7% (era al 18,9% a gennaio) e in Italia, pur rimanendo doppia rispetto alla media europea, decelera al 28,2% (era 42,8% a gennaio e 65,1% a dicembre 2022, risultando il tasso inflazione energetica più alto d'Europa). A febbraio 2023 i prezzi dell'energia salgono del 21,6% in Germania, del 14,0% in Francia mentre sono in controtendenza in Spagna, dove diminuiscono dell'8,8%.
Cresce l’inflazione di fondo - netto dell’energia e degli alimentari freschi - che in Eurozona passa dal 7,1% di gennaio al 7,4% di febbraio e in Italia, rispettivamente, dal 6,6% al +7,0%. Nonostante le tensioni crescenti sui mercati finanziari, a seguito del segnale di crescita della componente di fondo la Bce lo scorso 16 marzo ha deciso un ulteriore aumento di 50 punti base dei tassi di riferimento, con un incremento complessivo di 350 punti base dalla fine del luglio scorso, un incremento inedito nella storia dell’euro per intensità e velocità.
La stretta monetaria continua a traslarsi sul costo del credito delle imprese. La più recente rilevazione relativa a gennaio 2023 mostra che il tasso sui nuovi prestiti fino a 250 mila euro, di riferimento per le imprese di minor dimensione, è del 4,38% con una crescita di 227 punti base in un anno concentrata per il 90,7% proprio nel periodo di stretta monetaria (+206 punti base tra giugno 2022 e gennaio 2023 in più a fronte di +250 punti base per il tasso ufficiale Bce nel periodo in esame).
All'aumento del costo del credito si sta accompagnando il rallentamento della dinamica dei prestiti - corretta per le cartolarizzazioni e le altre cessioni – che per le società non finanziarie registra una sostanziale stabilità, con +0,1% a gennaio 2023 che segue la 'crescita zero' a dicembre 2022.
Il rialzo del costo del credito influenza i piani di investimento, ma, almeno per ora, l’Italia registra una evidente resilienza rispetto agli altri paesi Ue. Nel quarto trimestre 2022 gli investimenti in Italia segnano una crescita congiunturale del 2,0% mentre calano in Eurozona (-2,8%); tra gli altri maggiori paesi Ue, si registra una flessione del 2,5% in Germania e del 3,7% in Spagna, mentre gli investimenti ristagnano in Francia (+0,3%).
Per quanto riguarda gli investimenti in macchinari nel quarto trimestre 2022 la crescita congiunturale è dell’1,9%, in rallentamento rispetto al +3,6% del trimestre precedente. In chiave tendenziale la crescita rimane robusta, pari al +9,9% (era 9,1% nel trimestre precedente).
L’andamento degli investimenti in macchinari sarà uno dei temi esaminati nel Rapporto Confartigianato Meccanica 2023 che l’Ufficio Studi presenterà giovedì prossimo, 30 marzo, al Villaggio Confartigianato al Mecspe di Bologna (Pad 26 Stand A 01).
Tasso di interesse alle imprese su nuove operazioni fino a 1 mln € e a 250mila € e tasso ufficiale di rifinanziamento Bce
Gennaio 2005-gennaio 2023, tasso medio % su totale prestiti non c/c a società non finanziarie e tasso ufficiale fino a marzo 2023 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia e Banca Centrale Europea
Dinamica congiunturale del volume degli investimenti nei principali paesi Ue
III e IV trimestre 2022. Variaz. % rispetto al trimestre precedente, dati stagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Dinamica tendenziale e congiunturale del volume degli investimenti in impianti e macchinari
I trimestre 2019-I trimestre 2023. Variaz. % dei dati in volume destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
STUDI – Siccità e crisi idrica, nel Centro-Nord esposte 91mila imprese con 1,1 milioni di addetti e il 27,8% del made in Italy
La Giornata mondiale dell’acqua che si celebra oggi, 22 marzo, quest’anno è caratterizzata da una grave crisi idrica conseguente alla siccità. Nel report dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si indica che il maggiore fiume italiano negli ultimi 30 giorni ha registrato valori di portata media prossime o inferiori al precedente minimo nel periodo 1991-2020, in alcuni tratti si registrano condizioni idrologiche di “siccità estrema”; la severità idrica rimane media in assenza di precipitazioni. Secondo la rassegna degli Osservatori per gli utilizzi idrici curata dall'Ispra uno scenario di severità idrica media si riscontra anche nel Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e in quello dell'Appennino Centrale.
Lo scorso 1° marzo il Governo ha istituito una Cabina di regia per intervenire sulla crisi idrica conseguente alla siccità in corso.
Le imprese manifatturiere esposte alla crisi idrica - Nel Centro-Nord, dove la severità idrica è media, nei dieci comparti manifatturieri con una più elevata intensità di utilizzo dell’acqua (con il 69,3% dei consumi di acqua delle imprese di produzione), operano 91mila imprese con 1 milione 108mila addetti, l'87,3% dell'occupazione nazionale di questo raggruppamento settoriale. Nei settori in esame nel Centro Nord le esportazioni del 2022 valgono 197,6 miliardi di euro, l'83,5% dell’export italiano in questi settori e il 27,8% del totale delle esportazioni dei prodotti manifatturieri made in Italy.
In questo perimetro di settori water intensive, nel Centro Nord operano 55mila imprese artigiane, pari al 60,4% delle imprese - in cui lavorano 246mila addetti, pari al 22,3% del totale. I dati per regione e provincia delle imprese e artigianato nei dieci comparti manifatturieri a maggiore uso di acqua - esaminati in collaborazione con l’Ufficio Studi di Confartigianato del Veneto – sono contenuti nell'Appendice statistica 'Crisi idrica'. Clicca qui per scaricarla.
In relazione al fabbisogno di acqua, nel terziario vanno considerate le imprese dei servizi alla persona di lavanderie, acconciatori ed estetisti, in cui si registra un maggiore consumo di acqua per uso imprenditoriale.
La siccità spiazza la produzione di elettricità di rinnovabili - Nel 2022 la produzione di energia idroelettrica è crollata del 37,7%. La minore produzione idrica per 16.919 GWh è stata solo in minima parte compensata dall’aumento di 2.919 GWh da fotovoltaico, mentre cala (-366 GWh) la produzione eolica. La copertura del fabbisogno delle fonti rinnovabili è scesa dal 35,4% del 2021 al 31,1% del 2022. Nei primi due mesi del 2023 la produzione idrica si riduce del 6,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La spesa pubblica è dimezzata rispetto l’Europa – Per fronteggiare l'emergenza idrica, ridurre le perdite e gli sprechi e riammodernare la rete delle infrastrutture idriche servono investimenti pubblici. In Italia la spesa pubblica per la gestione dell'acqua – i capitoli di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque reflue – nel 2021 ammonta a 2,2 miliardi di euro, pari a 37 euro per abitante, meno della metà (-52,2%) dei 77 euro per abitante della spesa media Ue, un livello ampiamente inferiore rispetto ai 66 euro della Spagna e ai 74 euro della Germania e meno di un terzo dei 122 euro della Francia. Nella media degli ultimi dieci anni la spesa pubblica per la gestione dell'acqua in Italia si è ridotta di quasi un terzo (-30,5%), mentre è salita in Francia (+6,7%) e in Germania (+7,0%).
Dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono attesi interventi per 4,4 miliardi di euro per garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche. A fine 2022 risultano conseguiti i 12 obiettivi previsti per la relativa missione del Piano M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica.
La spesa delle famiglie per l’acqua potabile - La spesa di una famiglia per l’acqua potabile è di 177 euro all’anno, registrando valori più elevati nel Centro (205 euro/anno) e Mezzogiorno (202 euro/anno), a fronte dei 194 euro/anno nel Nord Est e il minimo di 117 euro/anno nel Nord-Ovest. Complessivamente, in Italia si stima una spesa delle famiglie nel 2022 di 4,5 miliardi di euro. Secondo la scomposizione della spesa media annua per una utenza domestica tipo (consumo annuo pari a 150 mc) pubblicata nella Relazione annuale di Arera, il 39,6% della spesa è imputabile al servizio di acquedotto, il 29,6% a quello di depurazione e il 12,8% per il servizio di fognatura. Infine, l'Iva pesa per il 9,1% e il rimanente 9% si riferisce alla quota fissa.
Le tendenze dei prezzi per la fornitura di acqua - A febbraio i prezzi al consumo della fornitura di acqua salgono del 4,2%, un trend prossimo a quello dell'Eurozona (4,4%) e inferiore a quello di Germania (+4,7%) , ma risultando un aumento più marcato rispetto a Francia (+2,6%) e Spagna (+1,2%). Più marcata la crescita dei prezzi alla produzione, che a gennaio salgono del 5,4%.
Una struttura di offerta frammentata - In un settore dove sono richiesti ingenti investimenti, pesa la polverizzazione della gestione dei servizi idrici, che nel 2020 conta 2.391 gestori, di cui 1.997 in economia (83,5%), ovvero enti locali, e 394 gestori specializzati (16,5%). Sono quasi duemila (1.965) gli enti che gestiscono le reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile. Nel settore della raccolta, trattamento e fornitura di acqua operano 742 imprese con 34.912 addetti e un fatturato di 9,1 miliardi di euro.
Le perdite della rete idrica – Le prospettive concrete di un razionamento dell’acqua danno un particolare significato alle perdite idriche che, dall'analisi dei dati pubblicati dall'Istat, sono pari a 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,2% dell’acqua immessa in rete, equivalente all'89,0% dei consumi della manifattura. Se consideriamo il costo medio variabile per acquedotto della tariffa del servizio idrico, si stima un controvalore delle perdite di 2,9 miliardi di euro.
Le anticipazioni dell’analisi dell’Ufficio Studi nell’articolo ‘Giornata mondiale dell’acqua, numeri e criticità del settore idrico’ pubblicato su QE-Quotidiano Energia
Imprese artigiane e totali nella manifattura water intensive nelle regioni del Centro-Nord
Marzo 2023, imprese attive anno 2020, divisioni Ateco 2007: 7,8, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Spesa pubblica per gestione acqua nei principali paesi Ue
2021, euro per abitante, classificazione Cofog 06.3 e 05.2 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Dinamica decennale spesa pubblica per gestione acqua nei principali paesi Ue
Media 2012-2021, var. % cumulata rispetto a media 2002-2011, classificazione Cofog 06.3 e 05.2 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
STUDI - Nel 2022 +10,6% occupazione giovani diplomati. Il report di Confartigianato sull’istruzione tecnico-professionale
I percorsi di istruzione tecnica e professionale interessano 1 milione 292 mila studenti, pari al 48,8% degli alunni delle secondarie, con valori superiori al cinquanta per cento in Veneto con 56,8%, Emilia-Romagna con 56,0%, Lombardia con 52,2%, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte con 52,1% e Puglia con 50,8%.
Un’alta qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale è un requisito necessario per sostenere l’occupazione dei giovani nei settori tipici del made in Italy e armonizzare domanda e offerta di lavoro, come evidenziato nell’Elaborazione Flash ‘Il valore dell’istruzione tecnica e professionale’ pubblicata venerdì scorso dall’Ufficio Studi con la Direzione Politiche sindacali e del lavoro di Confartigianato, integrata dall’Appendice statistica ‘Istruzione tecnica e professionale: dati per regione e provincia’.
Alcune delle evidenze del report sono state esaminate nell’articolo ‘Istruzione tecnico-professionale, asset strategico per la produzione del made in Italy’ a firma di Enrico Quintavalle, Responsabile dell'Ufficio Studi, pubblicato nell’ultimo numero di Spirito Artigiano.
Le entrate previste con titolo secondario tecnico, qualifica o diploma professionale caratterizzano il 63,2% della domanda di lavoro delle imprese; tra le maggiori regioni valori più elevati e superiori alla media in Toscana con 67,7%, Veneto con 66,7%, Puglia con 65,7%, Sicilia con 64,4% ed Emilia Romagna con 63,5%. Tra le maggiori province più elevata la domanda di personale con istruzione tecnica e professionale a Vicenza con 72,1%, Ancona con 70,7%, Perugia con 70,1%, Latina con 69,9%, Bolzano con 69,5%, Lecce con 68,7% e Treviso con 68,4%.
Risulta difficile da reperire 1 milione 377mila entrate con istruzione tecnico-professionale, pari al 42,0% delle entrate con questo livello di istruzione. Più della metà delle domanda è di difficile reperimento per gli indirizzi di livello secondario di elettronica ed elettrotecnica (59,8%) e meccanica, meccatronica ed energia (56,2%) e tra le qualifiche di formazione o diploma professionale, per gli indirizzi di impianti termoidraulici (61,9%), elettrico (54,7%) e meccanico (51,5%). Per il 43,0% delle entrate di lavoratori con diploma tecnico secondario superiore o qualifica e diploma professionale è richiesta una elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, mentre nel 33,1% dei casi le imprese attribuiscono una elevata importanza alle competenze digitali.
Il dinamismo dell’occupazione dei giovani diplomati - L'analisi dei dati annuali sul mercato del lavoro pubblicati nei giorni scorsi da Istat evidenzia una marcata crescita dell'occupazione dei giovani fino a 29 anni (+8,3%), trainata dai giovani occupati diplomati, saliti del 10,6% a fronte del +9,5% dei giovani laureati, mentre scende dello 0,7% l’occupazione dei giovani con basso titolo di studio. In crescita a doppia cifra (+14,8%) anche l’occupazione dei diplomati con meno di 25 anni.
È diffuso sul territorio il fenomeno del maggiore dinamismo dei giovani diplomati, più accentuato nel Nord Est con +15,7%, di sei punti superiore al +9,7% del totale giovani under 30, seguito da Centro con +9,5% (+9,9% totale under 30), Nord Ovest con +9,4% (+9,0% totale under 30) e Mezzogiorno con +7,4% (di 2,6 punti superiore al +4,8% totale under 30).
Secondo l’ultima rilevazione sui diplomati nel mercato del lavoro svolta da Almadiploma (2023), si rileva una tendenza di lungo periodo di aumento dei contratti a tempo indeterminato, mentre le retribuzioni mensili nette nel 2022 segnano un aumento del +16,9% rispetto al 2018.
Quota di entrate previste con titolo secondario tecnico, qualifica o diploma professionale
2022, % entrate - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Anpal
Dinamica occupazione under 30 diplomati e totale per ripartizione
2022, var. % occupati 15-29 anni - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat