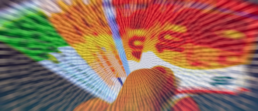STUDI – Pagamenti PA: 37 miliardi di euro oltre i termini di legge e 1.047 comuni che pagano oltre 60 giorni
L'aumento in corso dei tassi di interesse pagati dalle imprese conseguente alla stretta monetaria della Bce per contenere l’inflazione, come documentato in una nostra recente analisi, sta generando tensioni sulla finanza d’impresa. La crescita degli oneri finanziari si associa all’aumento dei prestiti per disporre della liquidità necessaria per pagare le bollette: le stime di Confartigianato indicano per il 2022 un maggiore costo per elettricità e gas di 23,9 miliardi di euro per le micro e piccole imprese rispetto all’anno precedente.
In questa fase delicata per la stabilità finanziaria del sistema delle imprese è necessario che lo Stato faccia la sua parte, garantendo pagamenti puntuali delle forniture alla Pubblica amministrazione, recuperando quelle situazioni ancora critiche a dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva europea (UE/2011/7) contro i ritardi di pagamento in vigore dal 2013 che sancisce il pagamento entro 30 giorni.
Come documentato nel 17°Rapporto annuale di Confartigianato, il confronto internazionale su dati della Commissione europea, condotto sulla sola parte di spesa corrente comprensiva delle anticipazioni, evidenzia che il debito commerciale della Amministrazioni pubbliche in Italia è pari al 2,9% del PIL; si tratta dell’incidenza più alta in Ue davanti alla Romania (2,3%) e alla Bulgaria (2,0%), superando nettamente l’1,7% della media Ue a 27 e della Germania, l’1,4% Francia e lo 0,9% della Spagna.
L’analisi del monitoraggio al secondo trimestre 2022 sui tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche indica che il tempo medio di pagamento delle fatture emesse nel primo semestre del 2022 si attesta a 40 giorni, con un miglioramento di 3 giorni rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (43 giorni), e in linea con i 40 giorni registrati nel totale del 2021. Il report del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato indica che “nonostante il miglioramento conseguito, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali espongono, alla fine del periodo di osservazione, un tempo medio di pagamento ancora significativamente elevato (56 e 41 giorni) rispetto ai requisiti di legge.”
Analizzando i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi a giugno 2022, si registrano pagamenti di fatture per 159,7 miliardi di euro, di cui 122,6 miliardi, pari al 76,8%, risultano effettuati entro i termini, mentre rimangono 37 miliardi di euro, pari al 23,2%, che sono realizzati in ritardo. In molti casi si tratta di ritardi leggeri, ma in altri casi, come vedremo più avanti, si delineano situazioni critiche e concentrate territorialmente.
Focus sui Comuni - L’analisi dei dati relativi alle Amministrazioni comunali – qui i dati al secondo semestre 2022 – si registra un tempo medio di pagamento di 32 giorni, in linea con la media calcolata per il totale delle Pubbliche amministrazioni.
Una analisi per ripartizione evidenzia che i tempi medi di pagamento dei Comuni sono di 42 giorni nel Sud e Isole, di 32 giorni nel Centro per scendere a 26 giorni nel Nord Est e 25 giorni nel Nord Ovest. La situazione è più critica nel Mezzogiorno, dove il costo del credito delle micro e piccole imprese è di 215 punti base superiori a quello del Centro Nord. Il dettaglio dei tassi di interesse per le imprese per regione nell’ultimo report di Confartigianato “Inizio 2023: prospettive e criticità per le imprese – Evidenze regionali”, qui per scaricarlo.
In chiave regionale i tempi medi più elevati si registrano per i Comuni della Calabria (54 giorni), seguiti dai comuni di Campania (48 giorni), Sicilia (46 giorni) Abruzzo e Basilicata (44 giorni) e Molise (43 giorni). All’opposto, le situazioni più virtuose si registrano per i Comuni in Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (24 giorni), Friuli-Venezia Giulia (22 giorni) e Veneto (21 giorni).
L’area critica - Nonostante il tempo medio di pagamento dei Comuni sia in linea con i requisiti di legge, va evidenziato che, dopo dieci anni in cui la Direttiva è in vigore, si contano ancora 1.047 Comuni - pari al 13,5% dei Comuni monitorati - che hanno ricevuto fatture nel primo semestre del 2022 per 2 miliardi di euro – che registrano tempi medi di pagamento superiori a 60 giorni, con una media di 78 giorni, oltre due volte e mezzo i termini di legge. Di questi, 630 comuni sono localizzati del Mezzogiorno, con una incidenza pari al 25,0% del totale delle Amministrazioni comunali della ripartizione, quasi tripla rispetto al 7,9% rilevata per i Comuni del Centro-Nord.
Debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche per beni e servizi nei paesi dell'Ue
Anno 2021. % PIL. Spesa parte corrente incluse anticipazioni. Debiti non in euro convertiti con tassi di cambio 2021 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea e Banca d’Italia
Tasso di interesse piccole imprese e tempi medi di pagamento dei comuni per ripartizione
tassi annuo effettivi a giugno 2022 e tempi medi pagamento I semestre 2022 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia e MEF-RGS
Tempi medi di pagamento dei comuni per regione
I semestre 2022, tempi medi pagamento in giorni, regione di appartenenza del comune - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati MEF-RGS
MEDIA - La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro. Il nuovo ‘quaderno’ della Fondazione Germozzi
La demografia è un problema prima di tutto economico. E’ stato molto chiaro, su questo punto, il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii durante l’assemblea annuale di Confartigianato. Un concetto, quello del saldo demografico, sul quale anche il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha riflettuto a lungo e che sta interrogando molti esperti della materia. D’altra parte, se già il nostro sistema economico sconta alcuni gap di competitività rispetto ad altri europei ed extraeuropei, quello della demografia rischia di essere un ulteriore fattore di squilibrio negativo. Ma il problema è molto più profondo e di non facile risoluzione. Di più: non riguarda solo il mondo delle imprese, ma è un problema che attiene alla tenuta strutturale del nostro Paese. Un’Italia sempre più vecchia, fragile.
Di questo e molto altro si è occupato Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica di Milano in molti dei suoi lavori. Alessandro Rosina è l'autore del nuovo ‘quaderno’ tematico della Fondazione dal titolo ‘La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro - Idee, spunti, dati e scenari per affrontare gli squilibri che rischiano di compromettere lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale del Paese’ (scarica il volume).
Gli studi compiuti da Rosina forniscono una proiezione, a tratti, piuttosto allarmante del problema demografico in Italia. Forse, però, la cosa più desolante è che a fronte di questo scoglio che sta via via diventando sempre più insormontabile, in questi anni abbiamo assistito a una sorta di grande rimozione collettiva. Come se il problema non ci riguardasse. Se a questo aggiungiamo che le politiche messe in campo per fronteggiare la questione demografica si sono rivelate del tutto inefficaci, ecco che il quadro appare ancor più a tinte fosche. La sfida dell’inversione del trend è attuale, attualissima. Una sfida per il futuro.
Spiega Rosina, intervistato da Federico Di Bisceglie per Spirito artigiano: "E’ senz’altro la grande questione rimossa del nostro paese. Non mancano i titoli di forte preoccupazione sui media quando escono i dati Istat sulle nascite in continua riduzione, ma dal giorno dopo il tema scivola sistematicamente ai margini del dibattito pubblico. La politica italiana tende ad avere uno sguardo corto, che fatica ad andar oltre il consenso da ottenere nelle prossime elezioni. La combinazione tra poca lungimiranza, bassa consapevolezza delle conseguenze della denatalità, marginalità delle politiche per i giovani e le donne, ha portato gli squilibri demografici a diventare sempre più gravi generando un senso di impotenza verso un destino ineluttabile. Anziché produrre una reazione si è via via scivolati verso la rassegnazione. Ci siamo permessi di sottovalutare questa enorme questione perché il centro della vita attiva è stato, fino a qualche anno fa, presidiato da generazioni molto consistenti. In particolare i nati attorno a metà anni Sessanta (all’apice del baby boom) avevano 35 anni nel 2000, 45 nel 2010 e 55 nel 2020. Gli effetti della denatalità sull’economia e sulla sostenibilità del sistema di welfare cominciano a prodursi ora con l’entrata nelle età lavorative dei nati dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi, quasi dimezzati rispetto alla generazione dei propri genitori. Non è più solo questione di conti pubblici, ma anche di squilibri che investono il mercato del lavoro". (Leggi l'intervista completa su Spirito artigiano)
Scarica il QFG ‘La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro' di Alessandro Rosina
STUDI – Costo credito: nel 2022 +170 punti tassi, con effetti negativi su investimenti, produttività e transizione green
L’inasprimento delle condizioni di politica monetaria per combattere l’inflazione sta determinando un rialzo del costo del credito alle imprese che - comprimendo la creazione di valore aggiunto - ha pesanti ricadute recessive sull’economia.
Nonostante il raffreddamento autunnale dei prezzi di petrolio e gas naturale, persiste sull’economia dell’Eurozona un alto tasso di inflazione, che a dicembre è al 9,2% (era 10,1% a novembre). In conseguenza di una maggiore spinta dei prezzi dell’energia, l’inflazione in Italia rimane in doppia cifra collocandosi al 12,3% (era 12,6% a novembre), mentre negli Stati Uniti la crescita dei prezzi al consumo rallenta al 6,5% (era 7,1% a novembre).
Per contrastare l’inflazione, la Bce ha deciso una vigorosa stretta monetaria, aumentando i tassi di interesse di riferimento di 250 punti base tra luglio e dicembre. La Bce ha preannunciato prossimi ulteriori aumenti dei tassi «in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine». Nella storia dell’euro non hanno precedenti l’intensità della stretta monetaria e la crescita dei prezzi attualmente in corso.
L’analisi delle ultime evidenze sul mercato del credito pubblicate da Banca d’Italia sottolinea la trasmissione della politica monetaria restrittiva sul costo dei prestiti per il sistema produttivo, che amplifica gli straordinari effetti della crisi energetica e caro bollette sui bilanci aziendali.
A novembre 2022 il tasso sui prestiti alle imprese per nuove operazioni con importo fino 1 milione è salito al 3,37% con un aumento di 170 punti base rispetto ad un anno prima, raggiungendo un livello che non si registrava da otto anni (novembre 2014). Solo a gennaio 2012, nel pieno della crisi del debito sovrano, con lo spread BTP-Bund a oltre 400 punti base, si registrò una crescita dei tassi sui prestiti più intensa (+176 punti base) di quella in corso.
Il tasso medio sulle consistenze dei prestiti alla imprese (società non finanziarie) in conto corrente arriva al 3,34%, salendo di 112 punti base nell’arco di dodici mesi.
Un approfondimento sul mercato del credito delle imprese nel report dell’Ufficio Studi ‘Finanza d’impresa, tra crisi energetica e stretta monetaria’. Qui per scaricarlo.
L’accentuata crescita dei tassi in corso potrebbe determinare una pesante frenata dell’economia. Secondo le recenti valutazioni del Fondo monetario internazionale, metà dell’Unione europea sarà in recessione, mentre si delinea il rischio di una eccessiva normalizzazione dei tassi ufficiali.
Nel terzo trimestre 2022, a fianco del rincaro dei tassi di interesse, cade la domanda di credito per gli investimenti. Con una ridotta accumulazione di capitale si determinano ricadute sulla propensione all’innovazione e sulla dinamica della produttività, mentre si frena la sostituzione di impianti meno efficienti, rallentando il contenimento dei consumi di energia e la transizione green delle imprese.
In un contesto di politica fiscale prudente l’aumento dei tassi fa salire la spesa per gli interessi sul debito pubblico, spiazzando gli interventi fiscali a sostegno degli investimenti delle imprese.
La stretta rallenterà il settore immobiliare e delle costruzioni, i comparti che hanno sostenuto la ripresa post-Covid-19: a novembre 2022 il costo dei prestiti per l’acquisto di abitazioni sale al 3,06%, con un aumento di 162 punti base rispetto un anno prima. Anche la spesa delle famiglie per beni di consumo durevoli e di autoveicoli viene penalizzata dall’aumento del costo del credito al consumo, il cui tasso a novembre è salito al 7,66%, con un aumento di 144 punti base in un anno.
Tassi di interesse bancari sui prestiti alle imprese fino a 1 milione di euro
Gennaio 2007-novembre 2022, società non finanziarie, nuove operazioni - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia